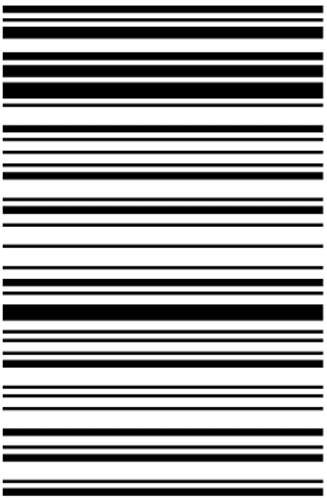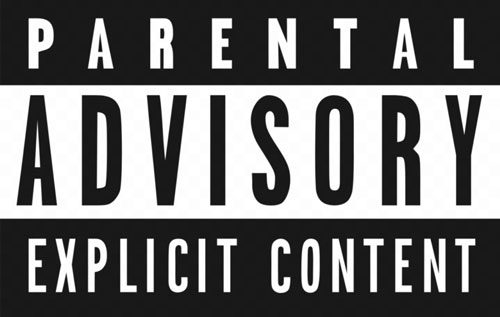Le imprese odierne si trovano a dover affrontare una lunga serie di questioni complesse: cambiamento climatico, diseguaglianza sociale crescente, polarizzazione del potere digitale, intelligenza artificiale, estremismi politici crescenti, etc.
Parafrasando Einstein, è impensabile che queste tematiche possano essere risolte con lo stesso paradigma economico che le ha generate.
Quale paradigma economico ha originato questi problemi? Verso quale paradigma dobbiamo slittare per risolverli? La ripresa del paradigma dell’economia civile costituisce una credibile via d’uscita dal nostro “disagio di civiltà”?
L’economia civile è una tradizione di pensiero che affonda le sue radici nell’Umanesimo civile del Quattrocento e che è continuata fino al suo periodo d’oro, quello dell’Illuminismo italiano. Mentre nel XXVIII secolo con Smith e Hume si delineavano in Scozia i principi della Political Economy, in Italia, negli stessi anni, prendeva corpo con Genovesi e altri studiosi l’economia civile.
Tra Scozia (economia politica) e Italia (economia civile) esisteva una differenza profonda.
Per Smith, la socievolezza dell’essere umano, cioè la relazionalità non strumentale, non era faccenda rilevante per il funzionamento dei mercati e dell’economia. Per Genovesi, invece, il mercato e l’impresa erano luoghi anche di amicizia, reciprocità, gratuità. L’economia civile non accetta l’idea o, meglio, l’ideologia, oggi diffusa e data per scontata, che il mercato sia qualcosa di diverso dal civile vivere: l’economia dovrebbe essere civile perché il mercato è vita in comune, e si dovrebbe basare sulla legge della mutua assistenza, che non è il solo mutuo vantaggio di Smith. Per il mutuo vantaggio basta il contratto, per la mutua assistenza occorre la reciprocità e la relazione. E così, negli ultimi due secoli e mezzo, si sono studiate solo le teorie dei contratti e dei prezzi, senza scomodare la categoria di persona: basta l’individuo ben informato e razionale. Eppure, i contratti sono incompleti (per via dell’informazione imperfetta e delle asimmetrie informative) e le persone sono costituite da relazioni, emozioni, credenze, valori e simboli.
Si deve, quindi, passare da un concetto dell’uomo economico homo homini lupus ad uno civile, per cui homo homini natura amicus, in cui la relazione è il bene principale nelle organizzazioni e nei mercati.
L’economia politica ha preso il sopravvento sull’economia civile grazie all’effetto trascinamento della prima rivoluzione industriale, relegando in un secondo piano l’economia civile che, via via, ha perso di forza. Abbiamo vissuto e stiamo vivendo, quindi, da più di due secoli secondo la logica dell’economia politica.
Ciò significa che si è accettata la separazione tra etica, politica ed economia: all’etica, regno dei valori, spetta il compito di dettare le norme che guidano il comportamento umano; alla politica, regno dei fini, il compito di definire per via democratica le mete che la società vuole raggiungere; all’economia, regno dei mezzi, il compito di ricercare i modi più efficienti per conseguire quei fini nel rispetto di quei valori. L’economia civile non accetta un tale principio di separazione, per l’ovvia ragione che al centro del discorso economico c’è pur sempre l’uomo nella sua integralità. Il mercato non è solo un meccanismo per l’efficiente regolazione degli scambi, è anche un meccanismo per l’attribuzione di potere e in quanto tale genera effetti di rilievo sul carattere degli uomini. Secondo la logica della separazione, un’azienda può decidere di tagliare la formazione non obbligatoria per favorire la crescita economica: l’economia (regno dei mezzi) diventa il fine ultimo, la politica (regno dei fini) si limita a implementare le decisioni economiche e l’etica (regno dei valori) è relegata in secondo piano: il risultato è un’azienda che sacrifica la salute dei lavoratori per il profitto economico. O, ancora, una concezione solo efficiente delle imprese ha generato l’eccessiva finanziarizzazione del capitalismo col risultato di una serie di crisi finanziarie che hanno devastato intere economie occidentali dagli anni ’90 in poi, licenziamenti di massa per giochi fiscali, etc.
Un secondo punto di differenziazione tra economia politica e civile riguarda il tipo di relazione tra i tre principi che sorreggono l’ordine di mercato:
– il principio dello scambio di equivalenti (di valore), con cui si ottiene efficienza allocativa,
– il principio di redistribuzione (di equità e giustizia sociale), per cui tutti possono partecipare al libero mercato,
– il principio di reciprocità e, quindi, di fraternità (concetto diverso dalla solidarietà: la solidarietà rende uguali i diseguali, la fraternità rende diversi gli uguali, per cui la disuguaglianza è un disvalore, la diversità è un valore).
L’economia politica tiene in considerazione solo i primi due principi, secondo il modello Stato – mercato: al mercato si chiede l’efficienza, la produzione di ricchezza, allo Stato la sua redistribuzione per garantire equità e giustizia sociale. Per l’economia civile tutti e tre i principi devono sorreggere l’ordine e devono farlo in modalità moltiplicativa e in contemporanea: non sono ammissibili trade-off tra gli stessi. Ad esempio, una società benefit cerca di operare in modo efficiente (scambio di equivalenti), si impegna in pratiche di redistribuzione (come salari equi per i dipendenti) e promuove la reciprocità e la fraternità (come investimenti in formazione, per le comunità locali, etc.). L’azienda, cioè, non cerca solo di massimizzare il profitto, ma di creare un impatto positivo sulla società e l’ambiente. L’efficienza, l’equità e la fraternità sono interconnesse e si rafforzano a vicenda.
Ne consegue il terzo punto di differenziazione: il fine ultimo. Per l’economia politica, è il bene totale, la sommatoria dei beni individuali (ben espresso dal PIL). Per l’economia civile è il bene comune, il prodotto, cioè, dei beni individuali. Stando nella metafora aritmetica, in una sommatoria, anche se alcuni addendi vengono annullati, la somma totale resta positiva. Ma in una produttoria, l’annullamento anche di un solo fattore azzera l’intero prodotto: non si può accettare, ad esempio, secondo l’economia civile, l’estrazione predatoria di materie prime in alcune parti del mondo per il sostentamento di stili di vita eccessivi in altre parti del mondo (a maggior ragione lo sversamento dei relativi rifiuti). Così come non si può accettare il licenziamento di centinaia di dipendenti in una parte del mondo per una riallocazione di un impianto produttivo per motivi fiscali. O ancora, non si può accettare una retribuzione di un top manager, ad esempio, duecento volte più alta di quella della media dei dipendenti di un’azienda.
Un’azienda non è sostenibile solo se riduce l’impatto ambientale, perché, mantenendo sempre lo stesso modello di business e paradigma culturale, quell’azienda continuerà a rincorrere il bene totale e non quello comune.
La grande sfida di oggi è culturale, bisogna andare oltre la tradizionale visione di economia di mercato, senza rinunciare ai vantaggi che essa ha finora assicurato. Si tratta di pensare l’uomo economico non più come massimizzatore di profitto (e idiota-sociali), bensì a persone in cerca di senso, che abbinano preferenze sociali ad auto-interesse, capaci di risolvere dilemmi sociali generando super-additività (per cui il valore complessivo generato dalla collaborazione tra persone è maggiore della somma dei singoli contributi individuali) e che assicurano la produzione di ricchezza, la redistribuzione sostenibile del reddito e lo sviluppo umano materiale, socio-relazionale e spirituale, in armonia.
Alcune parti di questo articolo attingono dal libro di L. Becchetti, L. Bruni, S. Zamagni, “Economia civile e sviluppo sostenibile. Progettare e misurare un nuovo modello di benessere”, Ecra, Roma 2019. In particolare, dalle due sezioni: “Gli enigmi di oggi e la storia degli indicatori di benessere”, di L. Becchetti, da pag. 17 a pag. 28 e “L’economia civile come berillo intellettuale”, di S. Zamagni, da pag. 70 a pag. 83.
Visita l’intera rubrica Safety shake!
Iscriviti alla community di rock’n’safe per ricevere contenuti esclusivi e inviti speciali ai nostri eventi!